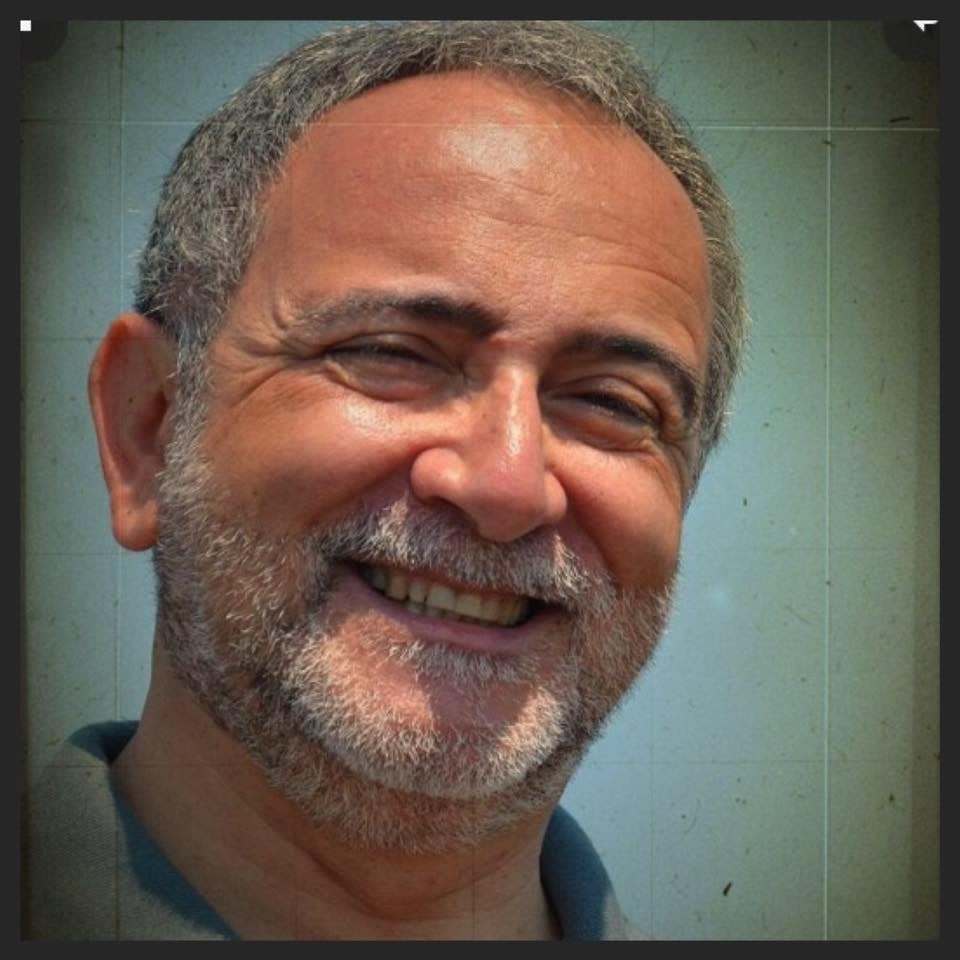SILENZIO, Bruno
Esci dalla solitudine e dai un nome al tuo dolore.
Dai miei anni di liceo ho imparato a coltivare una sottospecie di vizio: non leggo mai un libro alla volta, ne inizio alcuni e ne porto avanti due o tre insieme, talvolta quattro, a seconda dai suggerimenti e dalle recensioni che mi attraggono. Loro restano là, accumulati da qualche parte e sgualciti da una matita che mi dice quanto tempo ancora ho ancora da regalargli. Alla fine, vai a vedere che mi accorgerò di aver speso più soldi in matite, che in opere letterarie.
Vorrei fare la stessa cosa con le persone della mia vita, scrutarle e riporle, convinto che ci sia la possibilità di un segno che faccia riprendere discorsi interrotti o legami disfatti. Così, lo so, non è, la matita del tempo non ha la stessa pazienza di quelle che uso come segnalibri e, soprattutto, quelli che conosco, come me, non hanno ancora una trama definita e conclusa. Penso a Dostoevskij che ci ha messo una esistenza per cercare la sua vita nelle storie degli altri. Scavando sempre più a fondo, arrivando fino ai sottosuoli dell’anima, spinto dalla ricerca di un senso che mantenesse in piedi il gioco di vivere.
Scrisse, appena venticinquenne, Le notti bianche: romanzo sentimentale dai ricordi di un sognatore. Una brevissima storia d’amore nata, intrecciata e conclusasi nella magia rarefatta di quattro notti. Solo quattro notti, brevemente sbiadite da un sole che non vuole addormentarsi. Sullo sfondo, le illusioni e le disillusioni di un uomo solo in cerca di costruire la sua storia, come ci dice: “Sono completamente senza una storia. Come si dice da noi, ho vissuto per me stesso, cioè completamente solo”.
L’inconcludente vicenda intessuta con Nastjen’ka (Natalina nella trasposizione cinematografica di Visconti), però, non codifica solo la sua di solitudine, Dostoevskij fa apparire e scomparire dinanzi agli occhi del lettore, la solitudine di ogni personaggio, perfino quella di ogni comparsa messa a contorno di un cuore che si agita invano.
Lo scrittore russo, tratteggia un’umanità che sembra lavorare, innamorarsi, attendere, lasciarsi, illudersi perché la solitudine non inghiotta nessuno, completamente; perché si conservi un chiarore nelle notti senza discorsi e senza compagnia. Affannati nella ricerca di “quell’attimo di vera beatitudine” che riempie la vita di un uomo.
La psicoanalisi non è estranea all’argomento, basti pensare alla distinzione tra solitudine triste e serena che ritroviamo negli scritti della Klein (la solitudine depressiva) e di Winnicott (la solitudine evolutiva). Oltre questo, ciascuno di noi ha fatto personale esperienza con la solitudine, ne abbiamo acquisito un senso veicolato dalle restrizioni della pandemia: il lockdown, le distanze interpersonali, la ridefinizione della nostra vita sociale ci hanno fatto fare i conti con un silenzio assordante che né social, né maratone streaming hanno saputo colmare. Il filosofo Byung-Chul Han, nel suo ultimo saggio: “La società senza dolore” (Einaudi 2021) scrive che questo improvviso scontro con il virus ha tolto alla vita, il vestito che le avevamo dato: “La vita viene spogliata di qualsiasi narrazione capace di generare senso: non è più ciò che si può raccontare, bensì ciò che si può misurare e conteggiare. La vita diventa nuda, oscena. Nulla promette durata.”. Siamo diventati, insomma, come il sognatore di Dostoevskij, ricacciati nell’abisso da amori improvvisati; da una vita imprevista e imprevedibile.
La cosa, non si completa in un’accezione negativa. Qualcuno ha conosciuto da vicino il proprio dolore, lo ha toccato, lo ha rivissuto, ci ha sbattuto il muso e non ci ha trovato un senso. Ancora. Anzi, talvolta sembra dissolverci ogni volta che lo fissiamo; ogni volta che viene a trovarci nelle nostre notti insonni.
E quel dolore, senza parole, senza trama e senza storia ci ha reso incerti, impauriti, sconfortati. Stanchi.
Come gli eroi antichi presentatici dai solenni proemi delle grandi epopee, siamo anche noi invischiati in un ἄλγος (dolore) insensato, ora naufraghi, ora traditori, ora falliti, ora afflitti. Confusi tra rischio e lontane resistenze. Sono uguali a noi, mentre si dimenavano tra quel “numero uno” e quel “numero due”. Spaesati tra demone interiore e destino.
Lontano da ogni epica, recentemente, ha raccontato questa battaglia, un film d’animazione (Luca – Pixar 2020). Sullo schermo vive un essere degli abissi che si innamora delle storie che prendono corpo sulla terraferma. Vorrebbe abitarla, conoscerla, abbandonando dietro sé le pacifiche e noiose abitudini familiari. Un amico lo precede e lo aiuta. Lo aiuta non come un maestro, ma offrendogli la sua istintività per combattere ogni ritrosia e spingendolo a dare un nome preciso alle sue paure, così da zittirle ogni volta che sarà richiesto, dalla vita, di buttarsi giù a rotta di collo per non perdersi la bellezza di ogni cosa: “Silenzio, Bruno!”.
Quel grido è un “numero uno” che trionfa sul panico, sulle fobie, sulle depressioni, sulle resistenze che abbiamo avuto in sorte, sugli incontri sbagliati che ci son capitati e di cui non abbiamo nessuna colpa.
“Silenzio, Bruno!”.
Il dolore ci sarà, forse per sempre, forse ancora per poco, ma, abbiamo il potere di farlo tacere, perfino nelle nostre notti bianche, perfino quando nessuno è restato ad ascoltarci, perfino quando tutto sembra perso, sconosciuto o la nostra stima è chiusa in fondo a chissà quale ricordo che ha chissà quale volto.
“Silenzio,…!” Capiamo per tratti e istanti brevissimi, che il nostro dolore ha avuto da sempre un nome.
E questo nome è diverso dal tuo.
L.A.
Potrebbero interessarti...
L’ Assente
L’ Assente Ci sono padri che lavorano soltanto e figli affannati che supplicano...
Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi
CNOP Professioni non regolamentate. (Palma) Psicologi se la legge viene...
Ma Io Esisto ?
Un lungo viaggio verso il " tibet " , alla ricerca della mia individualità....